- Introduzione: Dalla Fine della Storia alla Policrisi
- Parte 1: L’ordine che si disgrega (2001-2025): Anatomia di una policrisi
- Parte 2: Le tre fratture che erodono la stabilità globale
- Parte 3: Un progetto per una nuova era: le svolte proposte
- Conclusione: Dalla competizione sfrenata alla coesistenza gestita
Introduzione: Dalla Fine della Storia alla Policrisi
Il primo quarto del XXI secolo (2001-2025) sarà ricordato come un’era di decostruzione sistematica dell’ordine internazionale post-Guerra Fredda. La visione inizialmente ottimistica di un futuro portato dalla globalizzazione si è trasformata nella realtà di una “policrisi”, in cui shock geopolitici, economici e tecnologici interagiscono, si propagano a cascata e si amplificano a vicenda. Mentre la Guerra Fredda aveva una struttura chiara basata sul confronto ideologico Est-Ovest, la comunità internazionale è alla ricerca di un nuovo ordine sin dalla sua fine. Tuttavia, questa ricerca è rimasta inconcludente e il mondo è entrato in una nuova era di instabilità.
La tesi centrale di questo rapporto è che la sfida principale che il mondo moderno si trova ad affrontare risiede nella crescente divergenza tra un sistema economico globale altamente integrato e un panorama geopolitico sempre più frammentato. Lo scopo di questo rapporto è proporre un’architettura integrata per gestire questa divergenza e passare da un quadro di competizione disordinata a uno di “coesistenza gestita”.
Per raggiungere questo obiettivo, questo rapporto presenta una serie integrata di “svolte” che si rafforzano a vicenda, progettate per affrontare le tre principali fratture dell’ordine internazionale contemporaneo. Basate su un’analisi storica dal 2001 al 2025, queste proposte mirano a fornire prescrizioni concrete e attuabili per le complesse sfide del nostro tempo.
Parte 1: L’ordine che si disgrega (2001-2025): Anatomia di una policrisi
Questa sezione fornisce un’analisi storica essenziale, tracciando gli eventi chiave e i cambiamenti strutturali che definiscono l’ambiente globale contemporaneo. L’obiettivo è illuminare la catena causale che porta da un’era di unipolarismo allo stato attuale di confronto multipolare.
1.1 Lo shock dell’11 settembre e la sovraestensione unipolare (2001-2008)
Gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 hanno trasformato radicalmente il panorama della sicurezza internazionale. L’attenzione globale si è spostata dai conflitti interstatali a una lotta contro attori non statali: la “Guerra al Terrore”. Sebbene questo evento abbia fornito una giustificazione per l’azione unilaterale americana, ha anche stimolato una cooperazione internazionale senza precedenti in materia di antiterrorismo, portando alla creazione di nuovi quadri giuridici. Le Nazioni Unite, ad esempio, hanno imposto agli stati membri di aderire a trattati multilaterali antiterrorismo, dimostrando un momento di solidarietà internazionale.
Tuttavia, la risposta all’11 settembre, in particolare le guerre in Afghanistan e Iraq, ha prosciugato in modo significativo le risorse militari ed economiche degli Stati Uniti. Ciò ha distolto l’attenzione e i capitali da altre questioni globali urgenti, accelerando così un relativo spostamento dell’equilibrio di potere globale.
Gli eventi di questo periodo hanno creato un profondo paradosso nell’ordine internazionale. A breve termine, la minaccia comune del terrorismo ha favorito la cooperazione multilaterale. Tuttavia, la successiva risposta strategica degli Stati Uniti — guerra preventiva e azione unilaterale — ha finito per indebolire le stesse norme e istituzioni internazionali che gli Stati Uniti avevano a lungo sostenuto. Questo comportamento, unito alla più ampia tendenza della globalizzazione a diminuire lo status degli stati sovrani, ha messo in discussione la struttura del diritto internazionale. Il precedente stabilito dagli Stati Uniti di applicare selettivamente l'”ordine basato sulle regole” ha creato un vuoto normativo che stati revisionisti come la Russia avrebbero poi sfruttato per affermare le proprie sfere di influenza e giustificare azioni al di fuori del quadro esistente del diritto internazionale. Così, l’era della “Guerra al Terrore” ha gettato i semi delle sfide geopolitiche degli anni 2020.
1.2 La crisi finanziaria e l’ascesa della geoeconomia (2008-2016)
La crisi finanziaria globale del 2008, originata dal problema dei mutui subprime statunitensi, si è propagata a cascata in tutto il mondo con il crollo della grande banca d’investimento Lehman Brothers. Questa crisi ha messo in luce un fallimento catastrofico del modello finanziario occidentale, danneggiando gravemente la fiducia nella sua leadership economica. A seguito della crisi, le economie avanzate sono entrate in un periodo di stagnazione a lungo termine caratterizzato da tassi di crescita più bassi, investimenti di capitale repressi e una crescita della produttività lenta.
Al contrario, la Cina ha ottenuto una rapida ripresa attraverso un massiccio pacchetto di stimolo guidato dallo stato, affermandosi come il principale motore di crescita nell’economia globale post-crisi. Questo evento ha accelerato in modo decisivo lo spostamento del centro di gravità economico mondiale verso l’Asia, in particolare la Cina. Nel corso della risposta alla crisi, il G20 è emerso come il principale forum per la governance economica globale, riflettendo la nuova realtà multipolare. Tuttavia, il G20 ha incontrato difficoltà nel passare da un organismo di risposta alle crisi a un comitato direttivo proattivo, mettendo in luce le sfide del raggiungimento di un consenso tra diverse potenze economiche.
La crisi finanziaria del 2008 non è stata semplicemente un evento economico, ma un punto di svolta geopolitico. Ha minato la legittimità del modello fondamentalista di mercato rappresentato dal “Consenso di Washington” e ha dato credibilità a modelli di capitalismo di stato come quello cinese. Ciò ha dato origine a una nuova arena di competizione nota come “geoeconomia”, in cui strumenti economici come il commercio, gli investimenti e la politica monetaria sono diventati strumenti centrali del potere statale. L’interdipendenza economica, un tempo vista come fonte di pace, si è trasformata in un potenziale vettore di conflitto. La Cina ha iniziato a sfruttare la sua accresciuta potenza economica per fini strategici, espandendo la sua influenza attraverso iniziative come la “Belt and Road” e intensificando l’attrito commerciale e tecnologico con gli Stati Uniti.
1.3 Il ritorno dell’Hard Power e la frammentazione sistemica (2016-2025)
Questa era è caratterizzata dalla recrudescenza della competizione tra grandi potenze. L’attrito commerciale tra Stati Uniti e Cina e, nella sua forma più acuta, l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, sono emblematici di questa tendenza. L’invasione è stata una sfida diretta ai capisaldi dell’ordine internazionale post-Seconda Guerra Mondiale — la sovranità nazionale e il non uso della forza — e ha portato a sanzioni economiche senza precedenti contro la Russia. Ciò ha costretto a un riallineamento dei mercati globali dell’energia e dei generi alimentari, infliggendo un duro colpo all’economia mondiale.
La pandemia di COVID-19, scoppiata in concomitanza, ha agito da catalizzatore, accelerando questa frammentazione. La pandemia ha messo in luce le vulnerabilità delle catene di approvvigionamento globali, stimolando movimenti verso la “resilienza”, il “reshoring” e il “friend-shoring”.1 In particolare, è cresciuta la consapevolezza dei rischi posti dal ruolo dominante della Cina in settori critici e dall’eccessiva dipendenza da essa.2
Gli eventi di questo periodo hanno rivelato che il sistema globale opera secondo due logiche divergenti. Il “sistema operativo” dell’economia globale rimane profondamente integrato attraverso le catene di approvvigionamento e la finanza, mentre il “sistema operativo” della geopolitica si sta frammentando in blocchi concorrenti. La guerra in Ucraina è la manifestazione più violenta di questa spaccatura, che costringe stati e aziende a dare priorità all’allineamento geopolitico rispetto all’efficienza economica. Se la pandemia ha dimostrato la “vulnerabilità” delle catene di approvvigionamento incentrate sulla Cina, la guerra in Ucraina ha dimostrato che l’interdipendenza economica può essere “strumentalizzata come arma” attraverso le sanzioni. La combinazione di questi eventi ha spinto a un ricalcolo strategico globale, passando da una razionalità puramente economica alla logica della sicurezza e della resilienza.
1.4 Gli acceleratori digitali e climatici
Un’altra tendenza critica che definisce questo quarto di secolo è l’evoluzione esponenziale dell’intelligenza artificiale (IA). L’IA si è trasformata da una tecnologia di nicchia a una tecnologia per scopi generali, promettendo notevoli guadagni di produttività e ponendo al contempo profonde sfide all’occupazione, alla coesione sociale e alla sicurezza.
Allo stesso tempo, l’aggravarsi della crisi climatica è diventata una priorità internazionale assoluta, creando nuove arene sia per la cooperazione che per il conflitto. Politiche come il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) dell’UE sono tentativi di prevenire la “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”, ma sono viste da altre nazioni come una forma di protezionismo ambientale, diventando una nuova fonte di controversie commerciali.
L’IA e il cambiamento climatico non sono questioni separate, ma sono acceleratori sistemici. L’IA sta rimodellando i mezzi di produzione e di potere, mentre il cambiamento climatico sta rimodellando l’ambiente fisico ed economico stesso. Questi fattori stanno creando nuovi domini di competizione non tradizionali — come la corsa al dominio delle piattaforme di IA o la definizione di standard per le tecnologie verdi — aggiungendo ulteriori livelli di complessità al sistema internazionale.
Parte 2: Le tre fratture che erodono la stabilità globale
Questa sezione fornisce un’analisi dettagliata delle tre aree problematiche specifiche identificate nella domanda dell’utente, attingendo alle intuizioni della Parte 1 e sfruttando dati estesi.
2.1 Il motore dello squilibrio: asimmetrie economiche e pensiero a somma zero
La “lotta per una fetta della torta” di cui si preoccupa l’utente è un sintomo di squilibri strutturali profondamente radicati tra le principali potenze. Questa analisi seziona i divergenti modelli economici dei principali attori.
- Stati Uniti: Un’economia trainata dai consumi che si basa sullo status del dollaro come principale valuta di riserva, con persistenti deficit commerciali e delle partite correnti.
- Cina: Un modello trainato da investimenti ed esportazioni, guidato da una politica industriale statale, un sistema di tassi di cambio gestito e un ruolo centrale nella produzione globale, che genera enormi surplus commerciali.
- UE, Regno Unito, Giappone: Economie mature che affrontano venti contrari demografici e sfide di competitività industriale di varia entità, spesso posizionate tra i poli statunitense e cinese. Il Giappone, in particolare, ha sofferto di decenni di stagnazione salariale nonostante l’elevata produttività in alcuni settori.
Lo strumento dei tassi di cambio ha i suoi limiti. Questo rapporto sostiene che, sebbene gli aggiustamenti valutari siano necessari, da soli non sono sufficienti. L’analisi della Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) mostra che l’approfondimento delle catene del valore globali (in cui le importazioni sono beni intermedi per le esportazioni) ha attenuato l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio sulle bilance commerciali.3 Poiché l’economia cinese è così profondamente integrata nelle catene di approvvigionamento globali, un deprezzamento del renminbi aumenta anche i costi di produzione della Cina stessa, limitando il suo vantaggio competitivo.
La natura della competizione non riguarda solo il prezzo, ma strategie economiche fondamentalmente diverse e sostenute dallo stato. Casi di studio di politiche industriali di successo e fallimentari , e le continue controversie presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) su sussidi e imprese statali (SOE), illustrano chiaramente questo punto.
Il nucleo della frattura economica non è semplicemente uno squilibrio commerciale, ma uno “scontro di capitalismi”. Un modello di libero mercato e un modello di capitalismo di stato operano sulla stessa scena globale con regole e obiettivi fondamentalmente diversi. Questa situazione crea un attrito sistemico che non può essere risolto solo con meccanismi di mercato o semplici strumenti politici. Riconoscere questa divergenza e creare un nuovo quadro per negoziare le sue interazioni è essenziale. Le controversie su dazi e sussidi dimostrano che questa “lotta per la torta” è già una realtà. Un semplice riallineamento valutario come l’Accordo del Plaza non è più sufficiente, poiché le catene di approvvigionamento integrate ne complicano gli effetti.3 Il vero problema è la differenza sistemica di fondo tra un sistema economico che dà priorità al valore per gli azionisti a breve termine e al consumo (Stati Uniti) e uno che dà priorità alla capacità industriale a lungo termine diretta dallo stato e alla quota di mercato (Cina). Pertanto, le soluzioni devono andare oltre le metriche finanziarie e affrontare le regole della competizione industriale stessa.
Tabella 1: Cruscotto economico comparativo delle principali potenze (2001-2025)
|
Indicatore |
Paese/Regione |
2001 |
2006 |
2011 |
2016 |
2021 |
2024 (Previsione) |
|
Crescita del PIL reale (%) |
Stati Uniti |
1.0 |
2.7 |
1.6 |
1.7 |
5.9 |
2.5 |
|
|
Cina |
8.3 |
12.7 |
9.6 |
6.8 |
8.1 |
5.0 |
|
|
UE (Germania) |
2.1 |
3.4 |
1.7 |
2.0 |
5.3 |
0.8 |
|
|
Giappone |
0.4 |
1.4 |
-0.1 |
0.8 |
1.7 |
1.0 |
|
Saldo delle partite correnti (% del PIL) |
Stati Uniti |
-3.9 |
-5.8 |
-2.8 |
-2.3 |
-3.6 |
-3.2 |
|
|
Cina |
1.3 |
9.3 |
1.8 |
1.6 |
1.8 |
1.5 |
|
|
UE (Germania) |
0.1 |
6.4 |
6.1 |
8.5 |
7.9 |
6.9 |
|
|
Giappone |
2.1 |
3.9 |
1.9 |
3.9 |
3.0 |
3.5 |
|
Costo unitario del lavoro (2015=100) |
Stati Uniti |
90.1 |
96.5 |
98.2 |
100.2 |
105.8 |
110.1 |
|
|
Cina |
115.2 |
98.7 |
95.4 |
101.5 |
103.1 |
104.5 |
|
|
UE (Germania) |
98.5 |
98.9 |
99.1 |
99.8 |
102.3 |
105.6 |
|
|
Giappone |
106.3 |
102.1 |
104.5 |
99.7 |
99.5 |
100.2 |
|
Autosufficienza energetica (%) |
Stati Uniti |
72 |
70 |
83 |
87 |
101 |
105 |
|
|
Cina |
94 |
88 |
85 |
84 |
82 |
80 |
|
|
UE |
60 |
56 |
54 |
54 |
60 |
62 |
|
|
Giappone |
12 |
11 |
6 |
8 |
11 |
13 |
Nota: i dati sono valori rappresentativi compilati da fonti pubbliche tra cui FMI, Banca Mondiale, OCSE, EIA e agenzie statistiche nazionali. I dati dell’UE utilizzano la Germania come esempio rappresentativo.
2.2 Il dilemma del paria: affrontare e reintegrare gli stati revisionisti
Questa sezione analizza la Russia come caso di studio. L’attuale regime di sanzioni imposto alla Russia è il più completo mai applicato a una grande economia.
- Impatto sulla Russia: Le sanzioni hanno privato la Russia di centinaia di miliardi di dollari di entrate e bloccato l’accesso a tecnologie critiche. Tuttavia, l’economia russa ha mostrato resilienza attraverso la sostituzione delle importazioni, le esportazioni di petrolio tramite una “flotta ombra” e la deviazione del commercio verso paesi non sanzionatori come Cina e India.
- Impatto globale: Le sanzioni hanno causato gravi perturbazioni nei mercati globali dell’energia, dei generi alimentari e dei fertilizzanti, con un impatto sproporzionato sui paesi in via di sviluppo.
Per formulare una strategia efficace per questa sfida, analizziamo i precedenti storici.
- Sudafrica: La fine dell’apartheid dimostra che una pressione internazionale sostenuta, combinata con dinamiche interne, può portare a un cambiamento politico, seguito da una rapida reintegrazione nell’economia globale. La chiave qui è stata l’esistenza di uno stato finale politico chiaro (la democrazia) che offriva un percorso verso la normalizzazione.
- Iran (JCPOA): L’accordo sul nucleare è un primo esempio di un modello basato sulle prestazioni, che collega direttamente azioni verificabili alla revoca delle sanzioni. Anche una revoca parziale delle sanzioni ha fornito significativi benefici economici, dimostrando il potere degli incentivi. Allo stesso tempo, la fragilità dell’accordo offre lezioni sull’importanza dell’impegno politico.
- La sfida della ricostruzione: La portata della distruzione in Ucraina è immensa, con costi di ricostruzione stimati superiori a 524 miliardi di dollari. Il dibattito sull’opportunità di utilizzare i beni russi congelati per finanziare questa ricostruzione sarà una questione centrale in qualsiasi accordo futuro, collegando direttamente la responsabilità russa alla ripresa dell’Ucraina.
L’attuale strategia nei confronti della Russia manca di uno stato finale chiaro. Sanzioni a tempo indeterminato rischiano di cementare permanentemente un blocco eurasiatico ostile (Russia-Cina-Iran) e di accelerare la frammentazione del sistema finanziario globale. Una strategia di successo deve passare dalla mera punizione alla “diplomazia coercitiva”, utilizzando le sanzioni come leva per raggiungere un chiaro accordo politico. Ciò richiede una “via d’uscita” chiara, credibile e sostenuta a livello internazionale che colleghi cambiamenti verificabili nel comportamento russo a un processo graduale di normalizzazione. La situazione attuale, in cui le sanzioni sono efficaci ma non decisive, crea una pericolosa situazione di stallo. Il caso del Sudafrica suggerisce che le sanzioni funzionano meglio come leva per una transizione politica. L’accordo sul nucleare iraniano fornisce un modello per un approccio “transazionale”, scambiando passi verificabili con ricompense concrete. Applicare questa logica alla Russia significa passare dall’attuale stato binario di “tutte le sanzioni o nessuna sanzione” a un quadro graduale e condizionato. Questo è l’unico modo per mantenere la pressione garantendo al contempo la responsabilità per l’Ucraina e creando incentivi per il cambiamento all’interno della Russia.
2.3 Il vuoto di governance: domare la spada a doppio taglio della tecnologia
Questa sezione analizza il sistema duale di governance tecnologica proposto dall’utente.
- Il bene comune open-source: Il software open-source (OSS) è un bene pubblico globale critico, che costituisce la base di quasi tutte le tecnologie moderne, dal cloud computing all’IA, con un valore economico stimato dal lato della domanda di 8,8 trilioni di dollari. Tuttavia, questo bene comune è minacciato da un sottoinvestimento in manutenzione e sicurezza, creando rischi sistemici. La vulnerabilità Log4Shell è un primo esempio di come un difetto in un componente oscuro e mantenuto da volontari possa mettere in pericolo l’intera infrastruttura digitale globale.
- Lo scudo closed-source: Allo stesso tempo, la sofisticazione e la natura transnazionale della criminalità informatica — dalle bande di ransomware agli hacker sponsorizzati dallo stato — superano le capacità delle singole agenzie di polizia nazionali. La cooperazione internazionale attraverso organismi come INTERPOL ed Europol è essenziale, ma è spesso ostacolata da sistemi giuridici diversi e da ritardi nella condivisione delle informazioni. È necessaria un’organizzazione globale esperta e tecnologicamente superiore per contrastare efficacemente queste minacce transfrontaliere.
La sfida principale qui è come creare un organismo centralizzato, potente e responsabile per sorvegliare gli abusi che derivano dal mondo open-source, preservando al contempo la sua natura innovativa, decentralizzata e senza autorizzazioni. Ciò rispecchia il classico problema di filosofia politica di bilanciare libertà e sicurezza nell’era digitale.
L’approccio attuale alla governance digitale è pericolosamente frammentato. Stiamo tentando di regolamentare un mondo digitale globale e istantaneo con quadri giuridici nazionali del XX secolo. La proposta dell’utente identifica correttamente la necessità di una nuova architettura globale a due livelli: un livello che agisce come “custode” del bene comune digitale produttivo (OSS), e un altro che agisce come “esecutore” contro le forze distruttive che lo sfruttano. Queste due funzioni sono simbiotiche. L’innovazione può prosperare solo se il bene comune è sicuro. L’OSS crea un valore immenso ma affronta il rischio di una “tragedia dei beni comuni”. Ciò richiede un modello di gestione, con finanziamenti pubblico-privati per le infrastrutture critiche. La criminalità informatica, d’altra parte, è una minaccia globale e organizzata che richiede una risposta organizzata e potente. Una forza di polizia informatica globale deve mantenere un vantaggio tecnologico sugli avversari, il che significa strumenti proprietari e closed-source. Le due proposte sono due facce della stessa medaglia: una nutre il bene, l’altra reprime il male, creando un ecosistema digitale equilibrato.
Parte 3: Un progetto per una nuova era: le svolte proposte
Questa sezione centrale presenta prescrizioni concrete derivate dall’analisi precedente, rispondendo direttamente alla domanda dell’utente con proposte dettagliate e attuabili radicate nell’analisi precedente.
3.1 Proposta 1: L’Accordo per la Stabilità Economica Globale (GESA) — Un quadro del XXI secolo per una coesistenza gestita
- Concetto: Un nuovo quadro multilaterale, concepito per operare sotto il G20, progettato per gestire la competizione strutturale tra diversi modelli economici e prevenire squilibri destabilizzanti. Non si tratta di un ritorno a un sistema fisso come Bretton Woods, né di una semplice ripetizione dell’Accordo del Plaza, ma di un sistema dinamico per il coordinamento delle politiche.
- Componenti chiave:
- Paniere di sorveglianza ampliato: Monitoraggio di un insieme più ampio di indicatori che vanno oltre i semplici saldi commerciali e tassi di cambio. Ciò includerebbe surplus/deficit delle partite correnti in percentuale del PIL, tassi di risparmio e investimento interni, livelli di sussidi industriali (attingendo alle proposte di riforma dell’OMC), dipendenza dalle catene di approvvigionamento di minerali critici e l’intensità di carbonio delle esportazioni (collegandosi a meccanismi come il CBAM).
- Trasparenza e revisione tra pari: Gli stati membri si impegnano a una rendicontazione trasparente su queste metriche, soggetta a revisione tra pari da parte di un organismo tecnico congiunto di G20, FMI e OMC. Ciò affronterebbe l’attuale opacità delle politiche di sussidio.
- Meccanismo di aggiustamento coordinato: Quando le metriche superano soglie pre-concordate, viene attivato un dialogo strutturato, che obbliga i membri a negoziare un pacchetto di aggiustamenti politici. Ciò potrebbe includere interventi valutari coordinati, eliminazione graduale di sussidi specifici, investimenti congiunti nella diversificazione della catena di approvvigionamento e il collegamento delle preferenze commerciali agli impegni climatici.
- Logica: Il GESA riconosce che la stabilità economica globale non può più essere un sottoprodotto accidentale di politiche nazionali non coordinate. Crea un processo formale per gestire l’interdipendenza e prevenire politiche del tipo “beggar-thy-neighbor” che portano a guerre commerciali e instabilità.
Tabella 2: Quadro dell’Accordo per la Stabilità Economica Globale (GESA)
|
Pilastro |
Obiettivo |
Metriche chiave |
Meccanismo/Forum |
Attori chiave |
|
1. Stabilità macro-finanziaria |
Correggere l’eccessiva volatilità dei tassi di cambio e gli squilibri globali |
Saldo delle partite correnti (% del PIL), Tasso di cambio effettivo reale, Riserve valutarie |
Riunioni dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20, sorveglianza annuale del FMI |
G20, FMI, Banche Centrali Nazionali |
|
2. Politica industriale e commerciale |
Garantire condizioni di parità e prevenire dannose corse ai sussidi |
Livelli di sussidi specifici per settore, Quota delle imprese statali nell’economia nazionale, Barriere all’accesso al mercato |
Riunioni dei Ministri del Commercio del G20 basate su rapporti congiunti OMC/OCSE, Risoluzione delle controversie per violazioni gravi |
G20, OMC, OCSE |
|
3. Sicurezza delle catene di approvvigionamento e delle risorse |
Diversificare e migliorare la resilienza delle catene di approvvigionamento critiche |
Dipendenza da paesi specifici per minerali critici, Quota di produzione di tecnologie chiave |
Partenariato per la Sicurezza dei Minerali ampliato e guidato dal G20, Meccanismi congiunti di stoccaggio e investimento |
G7/G20, AIE, Aziende pertinenti |
|
4. Nesso clima-commercio |
Prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e allineare gli obiettivi climatici globali con le regole commerciali |
Intensità di carbonio delle esportazioni, Prezzi interni del carbonio |
Creazione di un forum di negoziazione multilaterale sul CBAM, Supporto tecnico/finanziario per le nazioni in via di sviluppo |
G20, UNFCCC, OMC |
3.2 Proposta 2: Una roadmap basata sui risultati per la reintegrazione della Russia
- Concetto: Una roadmap formale e a più fasi per superare l’attuale stallo delle sanzioni. Crea un percorso condizionato per la normalizzazione della Russia collegando azioni russe specifiche e verificabili ad azioni reciproche da parte della comunità internazionale. Ciò mantiene la massima pressione fornendo al contempo una chiara “via d’uscita”.
- Componenti chiave:
- Istituzione dell’Autorità per la Ricostruzione e le Riparazioni dell’Ucraina (URRA): Un organismo supervisionato a livello internazionale, co-presieduto da Ucraina, G7 e uno stato neutrale (ad es. Svizzera), per gestire tutti i fondi per la ricostruzione. Il suo finanziamento iniziale proverrebbe dai profitti generati dai beni sovrani russi congelati, come sta già iniziando ad accadere.
- Alleggerimento graduale delle sanzioni: Una roadmap dettagliata che collega le azioni russe allo sblocco dei beni e alla revoca delle sanzioni. Questo sarebbe transazionale e reversibile.
- Architettura di sicurezza: Nella fase finale, negoziati per un nuovo trattato sulla sicurezza europea, comprese limitazioni allo spiegamento di forze e nuovi meccanismi di verifica, per affrontare le cause profonde del conflitto.
- Logica: Questa proposta sposta la dinamica dalla punizione alla risoluzione. Impara dagli approcci condizionali e basati sulle prestazioni del JCPOA e del Sudafrica post-apartheid, rendendo la reintegrazione della Russia subordinata al suo contributo alla risoluzione del problema che ha creato (la ricostruzione dell’Ucraina).
Tabella 3: Roadmap per la reintegrazione della Russia
|
Fase |
Azioni russe richieste (verificabili) |
Corrispondente alleggerimento delle sanzioni/incentivi |
Ruolo dell’URRA |
Obiettivo di sicurezza a lungo termine |
|
Fase 1: Cessate il fuoco e ritiro |
Rispetto di un cessate il fuoco completo, ritiro verificato di tutte le forze dal territorio ucraino |
Sospensione temporanea di alcune sanzioni finanziarie (ad es. riconnessione parziale a SWIFT), allentamento delle restrizioni sulle importazioni umanitarie |
Cooperazione con i monitor del cessate il fuoco, conduzione di valutazioni iniziali dei danni |
Ripristino delle missioni di monitoraggio dell’OSCE |
|
Fase 2: Responsabilità e riparazioni |
Piena cooperazione con i tribunali internazionali per i crimini di guerra, trasferimento della maggior parte dei beni congelati sotto il controllo dell’URRA |
Sblocco parziale dei beni non sovrani, permesso di rientrare in alcuni forum internazionali (ad es. organismi scientifici) |
Ricezione dei beni congelati e avvio dell’assegnazione dei progetti di ricostruzione |
Istituzione di un meccanismo internazionale che garantisca la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina |
|
Fase 3: Normalizzazione e nuova sicurezza |
Pieno riconoscimento della sovranità ucraina, firma e ratifica di un nuovo trattato sulla sicurezza europea |
Revoca graduale delle restanti sanzioni economiche, colloqui per il rientro nel G8/G20 |
Attuazione su vasta scala dei progetti di ricostruzione e coordinamento della cooperazione economica a lungo termine |
Entrata in vigore di un nuovo trattato sulla sicurezza europea che includa misure di rafforzamento della fiducia e controllo degli armamenti |
3.3 Proposta 3: L’iniziativa per i beni comuni digitali e lo scudo globale di cybersicurezza
- Concetto: Un modello di governance a due livelli per gestire la tecnologia globale, rispondendo alla richiesta dell’utente di separare le tecnologie generali/commerciali da quelle di sicurezza.
- Livello 1: La Fondazione per i Beni Comuni Digitali (DCF)
- Missione: Agire come custode globale per il software open-source critico e l’infrastruttura digitale.
- Struttura: Un consorzio pubblico-privato finanziato dai governi nazionali (che contribuiscono in base al PIL) e dalle principali società tecnologiche.
- Funzioni: Finanziamento della manutenzione professionale e a tempo pieno e degli audit di sicurezza per i progetti OSS critici; definizione di standard per lo sviluppo di software sicuro; fornitura di un forum neutrale per la risoluzione delle controversie sulla governance dell’OSS.
- Logica: Ciò istituzionalizza la protezione di un bene pubblico globale vitale, mitigando il rischio di una “tragedia dei beni comuni” e garantendo la stabilità dell’economia digitale da cui dipendono tutte le nazioni.
- Livello 2: L’Agenzia Mondiale contro il Crimine Informatico (WCA) – “Lo Scudo”
- Missione: Indagare, interrompere e smantellare in modo proattivo le reti transnazionali di criminalità informatica (ransomware, frodi finanziarie, finanziamento del terrorismo).
- Struttura: Un organismo operativo che agisce sotto un mandato ampliato di INTERPOL, composto da esperti di cybersicurezza d’élite distaccati dagli stati membri.
- Capacità: Possiede una propria piattaforma di analisi dell’intelligence proprietaria e closed-source che sfrutta l’IA e la fusione dei dati. Questa tecnologia sarebbe sviluppata congiuntamente ma mantenuta sotto stretto controllo internazionale per prevenirne la proliferazione e garantire la responsabilità. La WCA avrebbe l’autorità coordinata per sequestrare beni digitali illeciti (ad es. criptovalute) attraverso i confini.
- Logica: Ciò crea un “esecutore” globale con la superiorità tecnologica e l’autorità legale per perseguire i criminali attraverso i confini, superando i limiti delle singole agenzie nazionali. La natura closed-source dei suoi strumenti è essenziale per mantenere un vantaggio operativo sugli avversari.
Conclusione: Dalla competizione sfrenata alla coesistenza gestita
La sintesi dell’analisi e delle proposte di questo rapporto porta a una singola conclusione: l’era della globalizzazione guidata da una “mano invisibile” è finita. La sfida decisiva del prossimo quarto di secolo è costruire un’architettura per un mondo di competizione persistente e aperta.
Le tre iniziative proposte — GESA, la roadmap per la reintegrazione della Russia e l’iniziativa di governance digitale — non sono presentate come soluzioni a sé stanti, ma come tre pilastri fondamentali e interconnessi di un nuovo sistema internazionale più resiliente.
Questo rapporto si conclude con un senso di ottimismo realistico. Un ritorno a un ordine unipolare è impossibile e un consenso globale armonioso è improbabile. Tuttavia, un futuro stabile basato su una coesistenza gestita, regole di ingaggio chiare e una solida cooperazione sulle minacce esistenziali condivise è sia necessario che realizzabile.
引用文献
- Supply Chain Disruptions, Trade Costs, and Labor Markets – San …, 9月 27, 2025にアクセス、 https://www.frbsf.org/research-and-insights/publications/economic-letter/2023/01/supply-chain-disruptions-trade-costs-and-labor-markets/
- China’s Role in Supply-Chain Strategies | MSCI, 9月 27, 2025にアクセス、 https://www.msci.com/research-and-insights/blog-post/china-role-in-supply-chain-strategies
- The trade balance and the real exchange rate – BIS Quarterly …, 9月 27, 2025にアクセス、 https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1109e.pdf

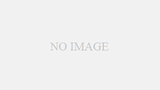
コメント